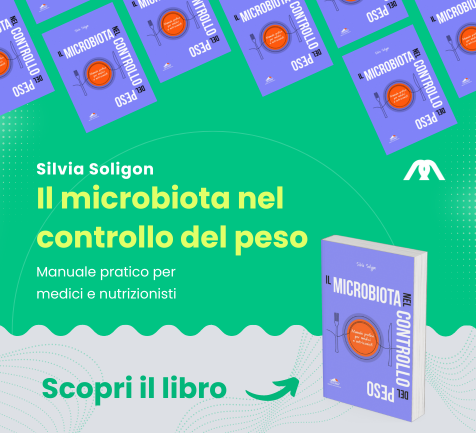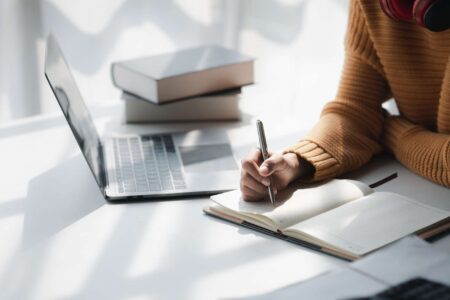Sono tornato da Percorsi nel Gusto con il taccuino pieno di appuntamenti segnati a matita e di profumi che non si lasciano archiviare. Cinque giorni, dal 6 al 10 ottobre, per attraversare il Cilento, salire verso Salerno e affacciarsi alla Costiera Sorrentina seguendo il filo rosso della Dieta Mediterranea, non come cartolina, ma come “farmaco” e come lingua viva che mette in relazione scienza, territori e persone.
È questo il cuore del roadshow promosso dalla Fondazione EBRIS insieme al Museo Vivente della Dieta Mediterranea e al GAL Approdo di Ulisse: un format itinerante, multisensoriale e replicabile, che unisce divulgazione rigorosa e esperienza diretta sul campo.
Le tappe del percorso
Un viaggio alla (ri)scoperta della Dieta mediterranea, che come un fiume carsico è nata nei campi, si è spostata sulle tavole, per poi tornare nel chiuso dei laboratori. E che oggi grazie anche alla ricerca sul microbioma torna a riveder le stelle e soprattutto a far parlare di sè.
A Pioppi, nelle sale del Museo Vivente, ho ritrovato l’essenza UNESCO della Dieta Mediterranea—patrimonio culturale immateriale dal 2010—non come elenco di regole ma come “diaita”, stile di vita e gesto collettivo: il pasto condiviso che diventa relazione, identità, memoria. Qui la sostenibilità non è slogan, è pratica quotidiana di stagionalità e biodiversità, un metodo che attraversa le aziende e le famiglie. Ogni pannello richiama una filiera corta che salva suolo e mari, riduce l’impronta ecologica e premia colture resilienti come cereali, legumi, ortaggi e frutta, mentre rimette al centro il valore educativo del cibo.
Tra le tappe più forti, la visita al Parco Archeologico di Velia: un varco temporale in cui la filosofia antica dialoga con la scienza moderna della nutrizione. Nei caseifici la mozzarella racconta fermenti e manualità, nei frantoi l’olio extravergine di oliva svela il suo lessico di polifenoli e cultivar, tra piante secolari e raccolte che scandiscono il calendario rurale. Ci sono state le alici nella loro nudità sapida, i limoni che profumano di salsedine, i pomodori che cantano d’estate anche in autunno, i fichi bianchi di Prignano che parlano di preservazione e di saperi, e quella pizza cilentana, povera e modernissima, che insegna ciò che la letteratura scientifica conferma: non è solo cosa mangiamo, è come, quando e con chi lo facciamo.
A Salerno il Giardino della Minerva ricama un ponte tra la Scuola Medica medievale e la ricerca biomedica contemporanea. È una delle cornici che preparano il convegno conclusivo alla Fondazione EBRIS, dove la Dieta Mediterranea rientra nell’orizzonte One Health: salute come equilibrio dinamico tra uomo, ambiente e società. In platea ci si riconosce tra amministratori, scienziati, nutrizionisti, produttori e comunicatori: rete vera, non retorica, con l’ambizione di esportare pratiche alimentari sane anche nelle mense scolastiche, aziendali e ospedaliere.

L’evento finale, tra musica e scienza
L’apertura dell’ultima serata, a sorpresa, è musicale, con il Coro Pop a Cappella del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno: un invito a pensare al ritmo, al tempo e alla misura, le stesse parole chiave che la Dieta Mediterranea impone alla nostra fisiologia.
Poi la parola passa alla scienza. Ronald E. Kleinman, dal Mass General Brigham for Children, richiama una verità scomoda: la Dieta Mediterranea è sotto attacco, stretta tra modelli globali “fast” che privilegiano la velocità al valore. Difenderla significa tutelare un patrimonio che il mondo ci invidia e uno strumento concreto di salute pubblica. È un appello che risuona perché attraversa l’intera settimana, dal campo alla tavola.
Alessio Fasano, presidente e direttore scientifico di EBRIS, utilizza la lente più fine: il cibo come medicina nei primi mille giorni di vita, quando nutrizione, microbiota e sistema immunitario si stringono in un patto che può indirizzare il destino clinico. Dal suo osservatorio, che va da Salerno a Boston, emerge un messaggio semplice e radicale: l’impatto della Dieta Mediterranea si misura quando scende dal podio dei convegni alle scelte quotidiane, quando diventa terapia accessibile fondata su sostenibilità, prossimità e consapevolezza.
Nitida Pastor e Cecilia Ricciardi Rizzo spostano il fuoco sul confine tra tradizione e innovazione, discutendo di obesità e patologie croniche: la Dieta Mediterranea resta un intervento strategico, validato da un crescente corpo di studi che ne riconoscono l’efficacia nel ridurre l’incidenza di malattie cardiovascolari, tumori e condizioni infiammatorie. Non è nostalgia gastronomica, è trasferimento tecnologico di pratiche culturali nel metabolismo delle comunità.
Fuori dalla sala, il racconto prosegue tra produttori e chef. Ogni degustazione è una lezione di chimica degli alimenti e di economia locale: l’olio che resiste all’ossidazione, il pomodoro che conserva licopene e memoria dei suoli, la pasta che tiene cottura perché trattiene granuli d’amido e, insieme, storie di grani antichi e di filiere virtuose. La Dieta Mediterranea, vista da vicino, è una piattaforma di sviluppo: ambientale quando preserva suolo e biodiversità, sociale quando educa alla stagionalità, economica quando genera valore per le imprese locali e il turismo enogastronomico, sanitaria quando alleggerisce la pressione sui sistemi di cura.
Se la tavola diventa Manifesto
L’ultima immagine, al tramonto, è l’aperitivo curato dallo chef Gian Marco Carli insieme al Consorzio Produttori Penisola Sorrentina DOP: un saluto che ha il sapore di un impegno. Qui la tavola diventa manifesto, la comunicazione chiede responsabilità—come ricordo durante la moderazione dell’incontro—e la ricerca promette di fare la sua parte, anche aprendo cantieri complessi come quello che indaga la relazione tra microbiota e disturbi dello spettro autistico. La Dieta Mediterranea non è un’icona immobile: è laboratorio, è politica del quotidiano, è infrastruttura culturale per la medicina che verrà.
Se qualcosa questa settimana ha insegnato è che “ritornare” non basta. Bisogna rilanciare, difendendo la Dieta Mediterranea dai modelli ultraprocessati che colonizzano gusti e tempi, e riportandola al centro della scuola, della città, della famiglia. Perché quel che chiamiamo tradizione, dentro Percorsi nel Gusto, è in realtà un progetto contemporaneo di salute pubblica, capace di far dialogare laboratorio e uliveto, pediatria e pescherecci, clinica e cucine. Un’eredità antica che, qui e ora, prova a farsi il farmaco più naturale e potente che abbiamo a disposizione.