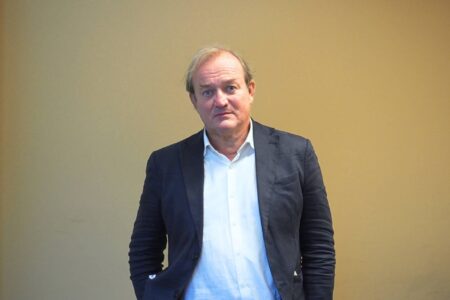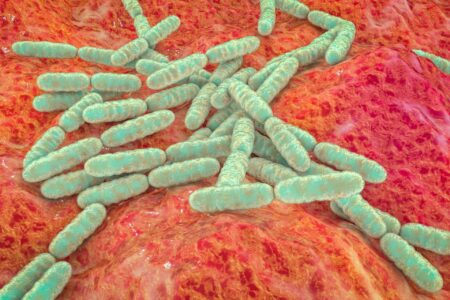Il microbiota intestinale svolge un ruolo centrale nella comunicazione tra intestino e cervello ed è in grado di modulare la risposta allo stress, non solo attraverso meccanismi di natura neurale ed endocrina, come si riteneva in passato, ma anche immunitaria. Da questa nuova prospettiva è emerso il concetto di asse intestino-immunità-cervello, oggi considerato un paradigma innovativo per comprendere i meccanismi alla base della salute dell’individuo.
Le ricerche più recenti hanno dimostrato che linfociti T e macrofagi possono infiltrarsi nel sistema nervoso centrale e svolgere funzioni essenziali che coinvolgono lo sviluppo neurologico, il mantenimento dell’omeostasi e la risposta alle malattie. La loro presenza nei tessuti cerebrali conferma l’esistenza di una rete che traduce i segnali periferici in risposte funzionali a livello encefalico.
Evidenze sempre più solide indicano che lo squilibrio della flora microbica, noto come disbiosi, possa contribuire all’attivazione o al mantenimento della neuroinfiammazione, sottolineandone il ruolo cruciale nei processi patologici (1, 2, 3).
Microbioma e stress, una relazione pericolosa
Tra le vie di comunicazione bidirezionale che collegano intestino e cervello, il nervo vago rappresenta una delle principali. Esso trasmette segnali sensoriali al sistema nervoso centrale e invia risposte che regolano la motilità gastrointestinale, le secrezioni digestive e la composizione del microbiota. Studi sperimentali hanno dimostrato che la stimolazione vagale riduce l’infiammazione, modulando l’attività dei macrofagi, al contrario, la vagotomia interrompe questo dialogo.
In tale contesto, caratterizzato da una complessa rete di segnali, la popolazione microbica gioca un ruolo chiave: essa partecipa al controllo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), via endocrina fondamentale coinvolta nella risposta allo stress. In tali circostanze, l’ipotalamo secerne l’ormone di rilascio della corticotropina che sollecita l’ipofisi a produrre adrenocorticotropo. Quest’ultimo agisce sulle ghiandole surrenali favorendo la secrezione di cortisolo, il principale ormone dello stress. Numerose cellule della mucosa gastrointestinale esprimono recettori specifici per il suo riconoscimento, confermandone un’interazione diretta.
Oltre ad influenzare l’asse HPA, la microflora contribuisce alla resilienza psicologica attraverso la produzione di metaboliti bioattivi, in particolare gli acidi grassi a catena corta (SCFA) come acetato, propionato e butirrato, derivati dalla fermentazione delle fibre alimentari. Queste sostanze influenzano l’attività immunitaria, riducendo l’attivazione della microglia e promuovendo un profilo antinfiammatorio. Inoltre, stimolano le cellule enteroendocrine a rilasciare peptidi che partecipano alla modulazione dell’umore e favoriscono la capacità dell’organismo di adattarsi a condizioni avverse. Studi preclinici hanno dimostrato che una dieta ricca di fibre, capace di stimolare la sintesi di SCFA, ha attenuato comportamenti ansiosi, migliorando la neuroplasticità dei circuiti cerebrali, al contrario, un’alimentazione povera di polisaccaridi non digeribili, è stata associata ad alterazioni morfologiche e deficit cognitivi.
Evidenze sperimentali rafforzano il legame tra comunità batterica e controllo delle funzioni emotive: nei modelli murini, il trapianto fecale da individui esposti a situazioni stressogene a soggetti sani induce comportamenti legati alla depressione, mentre il trasferimento da donatori in salute, riduce l’infiammazione sistemica nei riceventi con effetti benefici sull’equilibrio immunitario e sul comportamento.
Tali osservazioni hanno aperto la strada a nuove strategie per supportare la salute mentale, evidenziando il potenziale degli psicobiotici, probiotici capaci di modulare la comunicazione lungo l’asse intestino-cervello, che si sono dimostrati efficaci nel favorire il benessere psicologico, la cognizione e la gestione del carico psicofisico. In particolare, ceppi appartenenti ai generi Lactobacillus e Bifidobacterium hanno contribuito a ridurre ansia e sintomi depressivi, probabilmente attraverso la modulazione di mediatori infiammatori e segnali neuroendocrini (1, 2, 3).
Equilibrio emotivo e salute mentale
Il microbiota intestinale partecipa al mantenimento dell’equilibrio emotivo e della salute mentale attraverso la produzione di neurotrasmettitori, neuromodulatori e metaboliti, che influenzano i processi cognitivi, affettivi e comportamentali.
Numerosi batteri intestinali partecipano direttamente alla sintesi di questi mediatori chimici. Alcuni producono dopamina a partire dalla levodopa, altri modulano la secrezione di serotonina nelle cellule enterocromaffini intestinali, mentre ceppi appartenenti ai generi Lactobacillus e Bifidobacterium sintetizzano GABA tramite la decarbossilazione del glutammato.
Sebbene tali molecole non siano in grado di attraversare la barriera ematoencefalica, i loro precursori riescono a farlo modulando la disponibilità cerebrale e influenzando umore e funzioni cognitive.
Anche i prodotti del metabolismo microbico, in particolare gli SCFA, svolgono un ruolo nella regolazione neuronale: l’acetato attraversa la barriera ematoencefalica e viene utilizzato dai neuroni ipotalamici per produrre GABA e lattato, influenzando la secrezione di neuropeptidi legati all’appetito e alla risposta allo stress; il butirrato stimola la neurogenesi, sostiene la memoria e modula l’attività delle cellule gliali, contribuendo a un ambiente cerebrale antinfiammatorio e favorevole alla plasticità neuronale.
Evidenze cliniche e sperimentali confermano il ruolo della disbiosi nella patogenesi di disturbi psichiatrici come ansia e depressione. Ad esempio, nel disturbo depressivo maggiore, si osservano alterazioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, infiammazione cronica di basso grado e disbiosi intestinale. Nei pazienti depressi si rileva un aumento di cellule immunitarie e di marcatori infiammatori, come la proteina C-reattiva, mentre batteri benefici come Coprococcus e Dialister risultano ridotti. Modelli preclinici hanno dimostrato che il trapianto di microbiota da pazienti depressi ad animali sani induce comportamenti depressivi, dimostrando un legame causale tra disbiosi e alterazioni dell’umore. Anche nel disturbo d’ansia sociale la composizione microbica risulta modificata, con una ridotta produzione di IL-17A e una minore espressione di ossitocina nelle aree cerebrali deputate alla regolazione emotiva.
Nei modelli animali germ free (privi di microbiota) si osservano profonde alterazioni dei comportamenti ansiosi e depressivi: l’assenza di comunità microbiche compromette la risposta allo stress, mentre la somministrazione di probiotici come Lactobacillus e Bifidobacterium aumenta la disponibilità di serotonina e dopamina, favorendo una maggiore resilienza psicologica.
La disbiosi intestinale può quindi innescare una risposta immunitaria disordinata che alimenta la neuroinfiammazione e la disfunzione dei circuiti cerebrali dell’umore. L’aumento di citochine e metaboliti proinfiammatori compromette la barriera ematoencefalica, facilitando la trasmissione di segnali infiammatori al sistema nervoso centrale. Questi processi, sostenuti da un’infiammazione cronica di basso grado, alterano la comunicazione sinaptica e favoriscono l’insorgenza di sintomi ansiosi e depressivi (1, 2, 3).
Microbioma e difese immunitarie
Il microbiota intestinale contribuisce allo sviluppo e alla regolazione del sistema immunitario, influenzando immunità innata e adattativa. Ciò avviene principalmente attraverso la produzione di metaboliti bioattivi, che modulano l’infiammazione sistemica e le risposte immunologiche, agendo sia tramite vie metaboliche dirette sia attraverso l’attivazione delle cellule periferiche.
Tra i principali mediatori di questo dialogo figurano gli SCFA, che favoriscono la differenziazione delle cellule T regolatorie (Treg) e la produzione di citochine antinfiammatorie, come l’interleuchina 10 (IL-10), con conseguente attenuazione delle risposte correlate alla reazione infiammatoria. Parallelamente, i recettori Toll-like (TLR) presenti sulle cellule immunitarie, riconoscono i pattern molecolari associati ai microrganismi e orientano la risposta verso la tolleranza o, in presenza di segnali di pericolo, la reazione difensiva.
Un ulteriore livello di controllo è fornito dalle immunoglobuline A (IgA), gli anticorpi predominanti nella mucosa intestinale, la cui produzione è stimolata dalla presenza di alcuni batteri intestinali. Le IgA, neutralizzano i patogeni, limitano la traslocazione batterica e contribuiscono al mantenimento di una composizione microbica equilibrata. Tuttavia, quando tale armonia si altera, come accade nei casi di disbiosi, la funzionalità della barriera intestinale può risultare compromessa, facilitando il passaggio di componenti microbiche nel circolo sistemico. Questa condizione, nota come “intestino permeabile” (leaky gut) può innescare un’attivazione immunitaria eccessiva, con effetti pro-infiammatori e possibili ripercussioni a livello periferico e centrale.
Fin dalle prime fasi della vita, il microbiota guida la maturazione del sistema immunitario, e alterazioni precoci della flora intestinale possono lasciare conseguenze durature sulla regolazione delle risposte immunologiche e sulla dinamica dei processi infiammatori dell’organismo. (2, 3).
Strategie di supporto al sistema immunitario
In questo contesto, un ruolo di particolare interesse è svolto da Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bl-04 (Bl-04). Numerosi studi clinici e sperimentali hanno evidenziato che l’assunzione di questo ceppo può contribuire a ridurre l’incidenza e la gravità delle infezioni delle vie respiratorie superiori, sebbene i meccanismi precisi alla base di tali effetti non siano ancora del tutto chiariti.
Nei modelli murini di infezione da virus influenzale A (H1N1), la somministrazione di Bl-04 ha determinato una significativa riduzione della carica virale nei polmoni e un miglioramento dei sintomi clinici. Questi risultati suggeriscono un potenziale effetto protettivo del probiotico, verosimilmente legato alla sua capacità di modulare la risposta immunitaria attraverso l’asse intestino-polmone. Negli studi clinici condotti sull’uomo, Bl-04 ha mostrato una riduzione del rischio di infezioni respiratorie acute, sebbene i risultati non siano sempre stati replicabili. Tale variabilità potrebbe dipendere dalle differenze tra ceppi probiotici, dai protocolli di somministrazione e dalle caratteristiche individuali dei partecipanti, come età, stato immunitario e composizione del microbiota di partenza.
Nel complesso, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bl-04 si conferma una potenziale strategia di supporto per rafforzare la risposta immunitaria e mitigare la gravità delle infezioni respiratorie virali (4).
Connessioni tra i tre livelli: stress, umore, immunità
Lo stress, soprattutto quando diventa cronico, rappresenta uno dei principali fattori in grado di alterare la composizione e l’equilibrio del microbiota, con effetti a cascata sul sistema immunitario e sul benessere psicologico.
L’attivazione prolungata dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e del sistema nervoso autonomo induce la secrezione di cortisolo e catecolamine, ormoni che, se prodotti in modo persistente, compromettono l’integrità della barriera intestinale e favoriscono la disbiosi. L’aumentata permeabilità della mucosa permette il passaggio di endotossine e componenti batteriche nel circolo sanguigno, attivando una risposta infiammatoria sistemica. Le citochine prodotte in questo contesto, come IL-6, TNF-α e IFN-γ, possono raggiungere il cervello, alterando la comunicazione tra neuroni e cellule gliali, influenzando la produzione di neurotrasmettitori e favorendo l’insorgenza di sintomi ansiosi e depressivi.
Questo intreccio di segnali ormonali, immunitari e microbici evidenzia come stress, infiammazione e umore siano parte di un circuito integrato.
Il mantenimento di una microflora ben bilanciata costituisce un elemento chiave per regolare l’interazione tra sistema nervoso, immunitario e metabolismo, rafforzando la capacità dell’organismo di adattarsi a stress, infiammazione e infezioni (1, 2, 3).
Contenuto realizzato in collaborazione con Coree srl.
Fonti
- Park JC, Chang L, Kwon HK, Im SH. Beyond the gut: decoding the gut-immune-brain axis in health and disease. Cell Mol Immunol. 2025 Aug 14. doi: 10.1038/s41423-025-01333-3. Epub ahead of print. PMID: 40804450.
- Foster JA, Rinaman L, Cryan JF. Stress & the gut-brain axis: Regulation by the microbiome. Neurobiol Stress. 2017 Mar 19;7:124-136. doi: 10.1016/j.ynstr.2017.03.001. PMID: 29276734; PMCID: PMC5736941.
- O’Riordan KJ, Moloney GM, Keane L, Clarke G, Cryan JF. The gut microbiota-immune-brain axis: Therapeutic implications. Cell Rep Med. 2025 Mar 18;6(3):101982. doi: 10.1016/j.xcrm.2025.101982. Epub 2025 Mar 6. PMID: 40054458; PMCID: PMC11970326.
- Zabel B, Mäkelä SM, Nedveck D, Hibberd AA, Yeung N, Latvala S, Lehtoranta L, Junnila J, Walters KB, Morovic W, Lehtinen MJ. The Effect of Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bl-04 on Influenza A Virus Infection in Mice. Microorganisms. 2023 Oct 17;11(10):2582. doi: 10.3390/microorganisms11102582. PMID: 37894240; PMCID: PMC10609243.