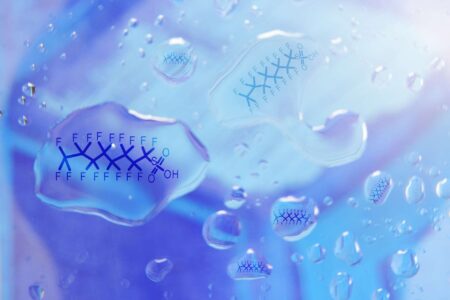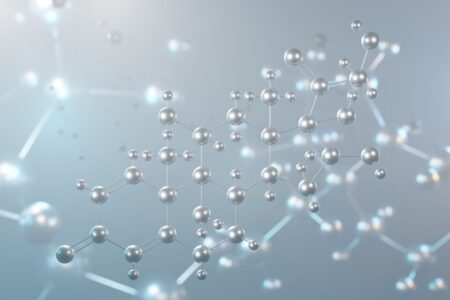Una recente revisione della letteratura realizzata da James Alexander (Imperial College London) e pubblicata sulla rivista Gut Microbes analizza in profondità le prove emergenti sul ruolo del microbiota intestinale come modulatore della risposta ai vaccini.
Nonostante i vaccini restino uno degli strumenti più efficaci nella prevenzione delle malattie infettive, la variabilità delle risposte immunitarie tra individui rappresenta una sfida tuttora irrisolta. Fattori tradizionalmente riconosciuti, come età, sesso, genetica e comorbidità, spiegano solo in parte queste differenze. Sempre più studi suggeriscono che una parte della risposta immunitaria sia modulata dalla composizione e dalle funzioni del microbiota intestinale.
Il microbiota intestinale è ormai considerato un regolatore chiave dell’omeostasi immunitaria. La colonizzazione precoce, già nei primi mesi di vita, contribuisce alla maturazione del sistema immunitario, mentre in età adulta la diversità e la stabilità della flora batterica influenzano il bilanciamento tra risposte innate e adattative.
Non sorprende, quindi, che la composizione del microbiota possa influire anche sull’immunogenicità dei vaccini somministrati per via parenterale, agendo tramite metaboliti a funzione immunomodulatrice come gli acidi grassi a catena corta e gli acidi biliari secondari.
Bifidobacterium in primo piano
Tra i generi batterici più spesso associati a risposte vaccinali più robuste spicca Bifidobacterium. Studi condotti in contesti diversi, dall’Asia all’Europa, hanno messo in evidenza come la presenza di B. adolescentis e B. bifidum prima della vaccinazione si associ a titoli anticorpali più elevati dopo l’immunizzazione contro SARS-CoV-2, epatite B, tetano e BCG. Nei neonati, in particolare, l’abbondanza di Bifidobacterium si è correlata a una migliore risposta cellulare e anticorpale a vaccini come PCV13 e Infanrix Hexa, suggerendo che il genere possa costituire un predittore consistente di efficacia vaccinale nei primi anni di vita.
L’influenza del microbiota non si limita alla sua composizione. I metaboliti microbici, come butirrato, acetato e propionato, possono plasmare la risposta immunitaria modulando la differenziazione delle cellule T e la produzione di anticorpi. Alcuni studi hanno mostrato che concentrazioni più elevate di acidi grassi a catena corta si associano a risposte anticorpali più solide, anche se i dati restano talvolta contraddittori. Allo stesso modo, una riduzione degli acidi biliari secondari, come conseguenza di terapie antibiotiche, si accompagna a un calo della risposta anticorpale a vaccini influenzali.
Il quadro che emerge è affascinante ma complesso. Se da un lato alcuni taxa – come Bifidobacterium, i produttori di butirrato (Faecalibacterium, Roseburia) o perfino batteri pro-infiammatori come Bilophila – mostrano associazioni ripetute con una migliore risposta immunitaria, altri come Segatella copri presentano un ruolo più ambivalente, legato a minori effetti collaterali ma anche a risposte anticorpali attenuate. La variabilità geografica, l’età e le condizioni cliniche dei pazienti introducono ulteriori sfumature, rendendo difficile delineare un “profilo microbico ideale” predittivo dell’efficacia vaccinale.
L’effetto di antibiotici e dieta
Se l’abbondanza di determinati taxa e metaboliti favorisce la risposta immunitaria, la disbiosi può comprometterla in modo significativo. L’uso di antibiotici, in particolare nei primi mesi di vita, altera la colonizzazione del microbiota riducendo la presenza di Bifidobacterium. Questo squilibrio si è tradotto in una ridotta produzione di anticorpi dopo vaccinazioni pediatriche e anti-influenzali.
La dieta gioca a sua volta un ruolo determinante: regimi ricchi di fibre favoriscono una maggiore immunogenicità, mentre diete ad alto contenuto di grassi sono state associate a un calo dell’efficacia vaccinale.
Prospettive future
La prospettiva di modulare il microbiota per potenziare la risposta ai vaccini è oggi oggetto di crescente interesse. Studi clinici hanno iniziato a valutare l’impiego di probiotici, prebiotici e simbiotici come coadiuvanti, con risultati promettenti ma ancora preliminari. Restano tuttavia sfide aperte, legate alla standardizzazione delle metodologie, alle differenze interindividuali e alle implicazioni logistiche ed etiche di un’integrazione del microbiota nei programmi vaccinali di routine.
L’evidenza accumulata, tuttavia, è chiara: il microbiota intestinale rappresenta un nuovo attore nella comprensione della variabilità vaccinale. In futuro, l’analisi e la modulazione mirata della flora batterica potrebbero aprire la strada a strategie personalizzate, capaci di rendere le campagne vaccinali ancora più efficaci e inclusive.
Per i medici, alcuni punti meritano attenzione:
- Uso di antibiotici: terapie antibiotiche, in particolare nel periodo neonatale e infantile, possono ridurre l’abbondanza di Bifidobacterium e compromettere la risposta immunitaria. È utile considerare questo fattore quando si pianifica il calendario vaccinale.
- Probiotici e integrazione mirata: dati preliminari suggeriscono che ceppi di Bifidobacterium e Lactobacillus possano sostenere la risposta immunitaria ai vaccini. Sebbene le evidenze non siano ancora sufficienti per raccomandazioni di routine, si tratta di un ambito promettente di ricerca clinica.
- Ruolo della dieta: un’alimentazione ricca di fibre può favorire la produzione di acidi grassi a catena corta, metaboliti associati a risposte anticorpali più robuste. Al contrario, regimi alimentari ad alto contenuto di grassi possono ridurre l’immunogenicità dei vaccini.
Con la sponsorizzazione non condizionante di