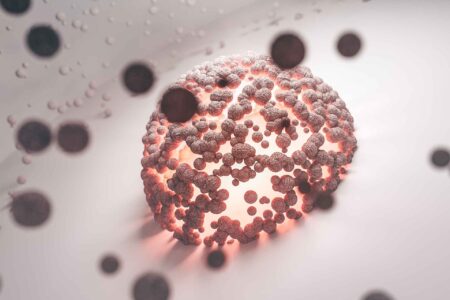I dati epidemiologici provenienti dall’Australia, dove la stagione influenzale 2025 si avvia alla conclusione, delineano uno scenario di particolare intensità. Si tratta della seconda stagione più severa degli ultimi dieci anni, con un tasso di incidenza elevato e un impatto rilevante sui sistemi sanitari locali. Come noto, l’andamento dell’influenza nell’emisfero australe rappresenta un indicatore utile per anticipare l’evoluzione della stagione influenzale in Europa.
«Anche se è ancora presto per fare delle previsioni precise in quanto molto dipenderà anche dall’andamento meteorologico, alla luce di tutto ciò non possiamo permetterci di trascurare i segnali d’allarme e dobbiamo farci trovare pronti. L’influenza non è mai da sottovalutare: sebbene spesso venga percepita come una malattia stagionale fastidiosa ma tutto sommato gestibile, essa rappresenta un rilevante problema di salute pubblica, capace di determinare ogni anno migliaia di ricoveri e non poche complicanze gravi, soprattutto nei soggetti più vulnerabili», sottolinea il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore scientifico di Osservatorio Virusrespiratori.it.
La peculiarità della stagione australiana è stata la co-circolazione di più agenti respiratori. In particolare, oltre al virus influenzale A (H1N1), è stato documentato un aumento significativo dei casi sostenuti dal virus influenzale B (lineaggio Victoria), meno frequente nelle ultime stagioni ma capace di generare un’elevata incidenza in età pediatrica e adolescenziale. A questi si sono aggiunti la circolazione del virus respiratorio sinciziale (VRS) e una ripresa della diffusione di SARS-CoV-2.
«I dati che ci arrivano dall’Australia non ci danno buone notizie, proprio perché quest’anno la stagione è stata molto intensa, con una co-circolazione di AH1N1, del virus B Victoria – una peculiarità di quest’anno – insieme anche a virus respiratorio sinciziale e Covid-19. Tutto questo ci fa pensare a una stagione con un inizio brusco da metà ottobre in poi, con una intensa presenza di virus che coinvolgerà dal 15 al 25% della popolazione» aggiunge Pregliasco.
Primi virus a ottobre
Le prime segnalazioni in Italia sono attese già da inizio ottobre, con un picco previsto tra novembre e dicembre. Entrambi i ceppi influenzali (A H1N1 e B Victoria) sono contemplati nella formulazione del vaccino antinfluenzale quadrivalente disponibile a partire da ottobre, secondo le indicazioni della circolare ministeriale.
L’attenzione clinica dovrà essere rivolta in particolare ai soggetti fragili: anziani, pazienti con comorbilità cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, donne in gravidanza e bambini piccoli. In queste categorie l’infezione influenzale può determinare complicanze severe, fino alla necessità di ricovero in terapia intensiva.
«Per fronteggiare uno scenario che si prospetta impegnativo, sarà fondamentale pianificare in modo adeguato le strategie di protezione vaccinale. La vaccinazione antinfluenzale è lo strumento più sicuro ed efficace per ridurre la circolazione del virus e soprattutto per limitare le conseguenze cliniche nei soggetti fragili. Per tali categorie, dato il leggero aumento dei casi Covid nelle ultime settimane, è consigliato approfittare della vaccinazione antinfluenzale per effettuare anche un richiamo vaccinale contro il Covid-19» conclude Pregliasco.
Medici di famiglia: «Abbiamo già chiesto le dosi di vaccino»
Anche il vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Stefano De Lillo, richiama l’attenzione sull’arrivo di una stagione influenzale che, sulla base dei dati provenienti dall’Australia, si preannuncia particolarmente virulenta. Il Servizio sanitario nazionale si è già organizzato per garantire le dosi necessarie di vaccino, strumento fondamentale non solo per proteggere individualmente bambini, anziani e pazienti fragili con patologie croniche, ma anche per creare un’immunità di comunità capace di ridurre ricoveri, complicanze e costi sanitari.
De Lillo sottolinea come la vaccinazione, sicura e collaudata, rappresenti una misura di prevenzione imprescindibile per tutelare la salute pubblica, contenere la pressione sui Pronto soccorsi e preservare il primato di longevità del nostro Paese.
Microbioma e sistema immunitario
I vaccini sono strumenti essenziali di prevenzione, ma la loro efficacia può variare in base a fattori genetici, ambientali e, come evidenziato da recenti studi, anche alla composizione del microbiota intestinale.
Una condizione di eubiosi favorisce infatti un’adeguata risposta immunitaria, mentre la disbiosi può ridurne l’efficacia. La dieta gioca un ruolo cruciale nel modulare il microbiota, influenzando così indirettamente la risposta vaccinale. I meccanismi coinvolti comprendono l’azione adiuvante di metaboliti e componenti microbici, la modulazione delle cellule dendritiche e T, e la produzione di acidi grassi a catena corta come il butirrato, in grado di potenziare la risposta anticorpale.
Diversi studi clinici hanno inoltre mostrato che l’integrazione con probiotici – ad esempio ceppi di Bifidobacterium e Lactobacillus – può aumentare la sieroconversione e i titoli anticorpali in neonati, adulti e anziani dopo la vaccinazione contro influenza, DTP e Covid-19. Nel complesso, mantenere un microbiota intestinale equilibrato, anche attraverso l’uso mirato di probiotici, emerge come un elemento chiave per ottimizzare l’immunogenicità dei vaccini nelle diverse fasi della vita.
Con la sponsorizzazione non condizionante di